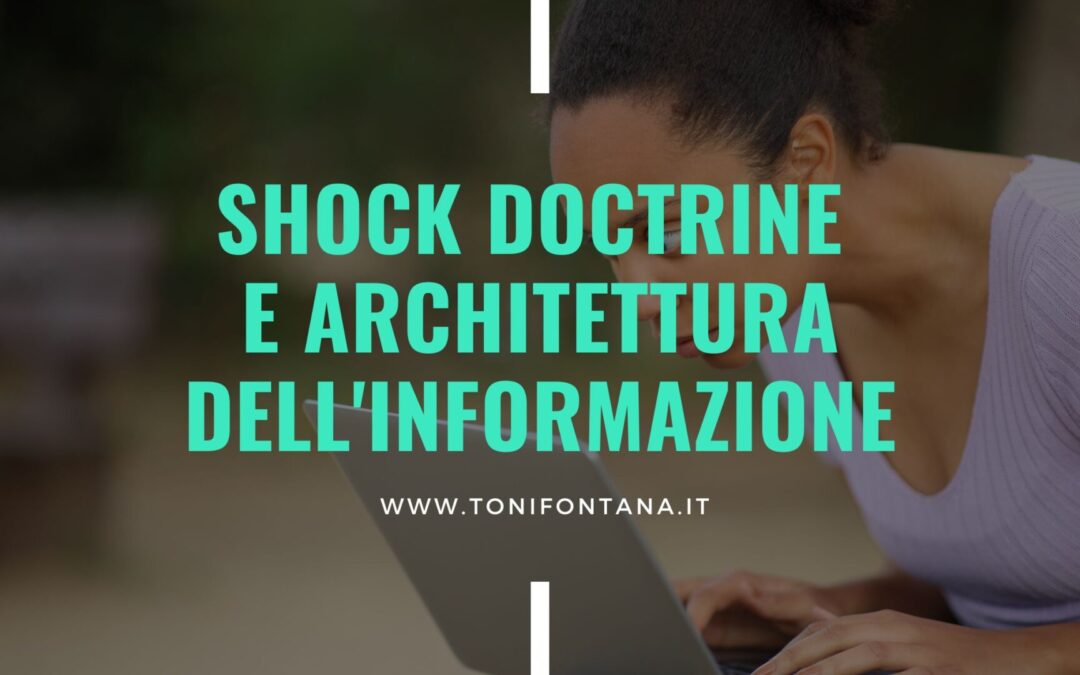Per comprendere appieno come la Shock Doctrine si applichi ai social media, è necessario esplorare il concetto di architettura dell’informazione, ovvero il modo in cui le informazioni sono organizzate sulle piattaforme digitali. Questa architettura non è neutra: è progettata per massimizzare l’attenzione degli utenti, spesso a scapito della loro capacità di elaborare le informazioni in modo critico e razionale.
La Shock Doctrine (o “Dottrina dello Shock”) è un concetto sviluppato dalla giornalista e scrittrice Naomi Klein nel suo libro The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007). L’idea centrale è che i governi e le élite economiche sfruttano crisi e disastri (guerre, catastrofi naturali, crisi economiche) per imporre politiche economiche impopolari che altrimenti la popolazione non accetterebbe.
Come funziona la shock doctrine?
Questo articolo è la continuazione del mio precedente Social media e shock doctrine.
Ci vado alla larga, con esempi macroscopici, per spiegare il funzionamento. Ma vale anche nel piccolo ormai.
Il meccanismo della Shock Doctrine si basa su una dinamica ricorrente.
Tutto inizia con un evento traumatico che destabilizza un paese o una comunità: può essere un colpo di stato, una crisi finanziaria o un attacco terroristico. La popolazione, disorientata e in cerca di soluzioni rapide, si trova in uno stato di vulnerabilità che i governi o le istituzioni internazionali sfruttano per introdurre misure radicali. Queste riforme, spesso ispirate ai principi del neoliberismo, includono privatizzazioni, tagli ai servizi pubblici e deregolamentazioni, favorendo grandi aziende e investitori a scapito dei cittadini. Una volta che la crisi si attenua e l’emergenza è passata, le nuove politiche si sono ormai consolidate, diventando difficili da revocare.
Diversi eventi storici dimostrano l’applicazione di questa strategia. Nel Cile di Pinochet, dopo il colpo di stato del 1973, gli economisti della scuola di Chicago guidati da Milton Friedman implementarono riforme economiche drastiche che ridisegnarono l’economia del paese. Durante la crisi argentina del 2001, le pressioni del Fondo Monetario Internazionale spinsero il governo ad adottare severe misure di austerità. Anche l’Iraq post-invasione del 2003 fu teatro di una massiccia privatizzazione delle industrie pubbliche, mentre dopo l’uragano Katrina del 2005, New Orleans vide la progressiva privatizzazione del sistema scolastico pubblico.
Perché è importante?
Comprendere la Shock Doctrine significa riconoscere i meccanismi attraverso cui il potere sfrutta i momenti di crisi per ridefinire l’assetto economico e politico di una società, spesso a discapito delle fasce più deboli. Essere consapevoli di questa strategia aiuta a interpretare in modo più critico le decisioni prese nei periodi di emergenza e a valutare le loro conseguenze nel lungo termine.
Il design delle piattaforme: trappole per l’attenzione
La Shock Doctrine sui social media funziona in modo simile al meccanismo descritto da Naomi Klein nel contesto economico e politico, ma con dinamiche adattate al digitale. Anche qui, la logica si basa sull’uso di momenti di crisi, shock o forte disorientamento per manipolare il pubblico e influenzare il comportamento delle persone.
I social media sono costruiti su algoritmi che privilegiano contenuti ad alto impatto emotivo. Post che suscitano rabbia, paura o indignazione hanno maggiori probabilità di essere visualizzati, condivisi e commentati. Questo meccanismo crea un flusso costante di informazioni drammatiche o polarizzanti, che possono lasciare gli utenti in uno stato di perenne allerta. Come nella Shock Doctrine, il caos non è un effetto collaterale, ma uno strumento per mantenere le persone disorientate e reattive.
L’architettura dell’informazione sui social media è pensata, dunque, per frammentare l’attenzione. Il design delle piattaforme, con il suo scorrimento infinito e le notifiche continue, incoraggia un consumo superficiale e frettoloso dei contenuti. Questo rende difficile per gli utenti approfondire o contestualizzare ciò che leggono, creando un terreno fertile per la disinformazione e la manipolazione.
In altre parole, il caos digitale non è solo un prodotto dell’abbondanza di informazioni, ma del modo in cui queste informazioni sono strutturate e presentate.
Il ruolo degli algoritmi: amplificatori di crisi
Gli algoritmi dei social media non sono neutrali. Gli algoritmi premiano contenuti che generano engagement, ovvero quelli che scatenano forti emozioni. Questo significa che post carichi di paura, rabbia o indignazione hanno più probabilità di diventare virali rispetto a quelli che promuovono una riflessione critica. Le piattaforme, consapevoli di questo, possono amplificare certe narrazioni a discapito di altre, favorendo gli interessi di chi ha il controllo del sistema.
Gli algoritmi dei social media agiscono come amplificatori di crisi. Quando un evento drammatico o controverso cattura l’attenzione del pubblico, i contenuti correlati vengono promossi in modo aggressivo, creando un effetto valanga. Questo fenomeno, noto come information cascade, può portare a una distorsione della realtà, in cui eventi isolati o marginali appaiono come emergenze globali.
Il risultato è un senso di urgenza e impotenza che ricorda da vicino lo stato di shock descritto da Naomi Klein.
In questo contesto, gli algoritmi non solo sfruttano il caos, ma lo alimentano attivamente.
Ad esempio, durante una crisi politica o sanitaria, i social media tendono a privilegiare contenuti sensazionalistici o estremi, trascurando fonti più equilibrate o approfondite. Questo non solo disorienta gli utenti, ma li rende anche più suscettibili a soluzioni semplicistiche o autoritarie, proprio come avviene nella Shock Doctrine.
La bolla informativa: isolamento e polarizzazione
Un altro aspetto cruciale dell’architettura dell’informazione è la creazione di bolle informative. Gli algoritmi personalizzano i contenuti in base ai comportamenti passati degli utenti, mostrando loro principalmente ciò che conferma le loro convinzioni preesistenti. Questo fenomeno, noto come filter bubble, non solo limita l’esposizione a punti di vista diversi, ma amplifica la polarizzazione e il conflitto.
Nella logica della Shock Doctrine, le bolle informative agiscono come camere di eco che amplificano il caos e il disorientamento. Gli utenti si ritrovano intrappolati in un ciclo di contenuti sempre più estremi, che alimentano la loro ansia e frustrazione. Questo li rende più vulnerabili a messaggi manipolativi o a soluzioni radicali, proprio come avviene in situazioni di crisi reale.
Una volta che l’emergenza si attenua, le nuove abitudini, politiche o idee imposte durante il momento di crisi restano in vigore. Ad esempio, le misure di censura introdotte in momenti di panico possono diventare permanenti, e la libertà di espressione sui social può essere limitata senza una vera opposizione. Oppure, una crisi economica può portare alla normalizzazione di modelli lavorativi più sfruttatori, che si radicano nella società come “inevitabili”.
La shock doctrine applicata ai social
Ricapitolando, su piattaforme come Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, gli eventi scioccanti – come guerre, pandemie, attentati, scandali politici o disastri naturali, ma anche la lotta politica cittadina, il pazzo del paese compie un atto di vandalismo o il cambiamento di una festa tradizionale – diventano contenuti virali in pochissimo tempo. I social, essendo progettati per favorire la diffusione rapida delle informazioni, amplificano queste crisi generando ondate di panico, indignazione o paura.
Quando una crisi esplode sui social, le persone tendono a reagire d’istinto, condividendo contenuti senza verificarne la fonte, commentando impulsivamente e contribuendo alla polarizzazione del dibattito. In questo momento, l’attenzione collettiva è focalizzata sull’emergenza, e chi gestisce il flusso di informazioni ha il potere di orientare l’opinione pubblica.
Introduzione di nuovi paradigmi o narrazioni
Durante questo stato di vulnerabilità, aziende, governi o gruppi con interessi specifici possono spingere nuove narrazioni, cambiando il modo in cui le persone percepiscono un problema. Alcuni esempi:
- Dopo un attacco terroristico, si può giustificare una maggiore sorveglianza sui social e la limitazione di alcune libertà in nome della sicurezza.
- Durante una crisi economica, alcune piattaforme possono favorire contenuti che normalizzano il precariato o il lavoro gratuito come “opportunità”.
- In una pandemia, le grandi aziende tech possono rafforzare il loro monopolio (ad esempio, attraverso il tracciamento digitale) presentandolo come una necessità.
Esempi concreti
- Facebook e Cambridge Analytica (2016): durante le elezioni statunitensi e il referendum sulla Brexit, i social sono stati usati per diffondere fake news e manipolare il voto sfruttando paure collettive (immigrazione, terrorismo, crisi economica).
- Guerre e conflitti geopolitici: durante momenti di tensione internazionale, i social vengono usati per alimentare campagne di disinformazione, polarizzando il dibattito e creando consenso per determinate azioni politiche.
Architettura dell’informazione e il potere di plasmare la realtà
L’architettura dell’informazione e la Shock Doctrine si intrecciano in modo profondo perché entrambe riguardano il modo in cui l’informazione viene strutturata, presentata e percepita. Se la Shock Doctrine sfrutta momenti di crisi per ridefinire il quadro politico ed economico, lo fa anche attraverso la manipolazione dell’informazione, che a sua volta dipende da come è organizzata e accessibile. Qui entra in gioco l’architettura dell’informazione: non è mai neutrale, perché ogni scelta su come presentare, catalogare e far emergere le informazioni influenza la comprensione e le decisioni delle persone.
L’architettura dell’informazione è molto più di una disciplina tecnica: è il modo in cui il mondo ci appare attraverso l’informazione.
Personalmente mi ha affascinato per il suo potenziale di rendere le informazioni più chiare e coerenti rispetto al contesto, aiutando le persone a orientarsi in sistemi complessi. L’utopia, se vogliamo, è quella di creare ambienti informativi che favoriscano la consapevolezza, la comprensione e la libertà di scelta, piuttosto che la manipolazione.
Shock Doctrine e manipolazione dell’architettura dell’informazione
Purtroppo, non tutti usano questa disciplina con finalità etiche. Chi detiene il controllo sull’architettura dell’informazione può decidere quali informazioni far emergere, quali vengono nascoste e in che modo vengono connesse tra loro.
E qui entra in gioco il legame con la Shock Doctrine: le crisi non solo destabilizzano le persone, ma creano opportunità per ridefinire il modo in cui l’informazione viene organizzata, veicolata e persino percepita.
Durante una crisi, l’architettura dell’informazione può essere distorta per orientare la narrazione in modo strategico. Questo avviene su diversi livelli:
- Categorizzazione e framing delle informazioni: il modo in cui un evento viene descritto incide su come viene compreso. Se un movimento di protesta viene classificato come “sommossa” invece che “rivendicazione sociale”, il suo significato cambia. In un contesto di Shock Doctrine, questa operazione è deliberata per favorire determinate reazioni e scelte politiche.
- Visibilità e accessibilità: chi controlla l’architettura dell’informazione può decidere quali contenuti sono più visibili. Durante le crisi, piattaforme digitali e media tradizionali possono amplificare certe narrative e oscurarne altre, influenzando la percezione collettiva.
- Strutturazione del caos: lo shock disorienta, e chi riesce a imporre un nuovo ordine informativo durante un momento di crisi guadagna un enorme potere. I governi e le grandi aziende tech spesso approfittano delle emergenze per ridefinire regole e strutture informative a proprio vantaggio, introducendo nuove regolamentazioni che diventano permanenti.
L’architettura dell’informazione come strumento di resistenza
Se l’architettura dell’informazione può essere sfruttata per manipolare e controllare, può anche diventare una forma di resistenza. Il vero potenziale di questa disciplina sta nel creare spazi informativi che favoriscano la comprensione e la consapevolezza, invece di alimentare il caos e la manipolazione.
Il mio personale fascino per l’architettura dell’informazione nasce proprio da questa tensione: da una parte, il desiderio di costruire sistemi che aiutino le persone a orientarsi, a comprendere il contesto e a prendere decisioni consapevoli; dall’altra, la consapevolezza che queste stesse tecniche possono essere usate per oscurare, distorcere e manipolare. L’utopia, forse, è quella di progettare ambienti informativi che resistano alle logiche di sfruttamento della Shock Doctrine, rendendo la conoscenza più accessibile, più trasparente e più coerente con i bisogni reali delle persone.
Come difendersi dal caos digitale
Di fronte dunque all’architettura dell’informazione progettata per creare caos, è fondamentale adottare strategie di difesa. Innanzitutto, è importante riconoscere che il disorientamento che proviamo non è casuale, ma il risultato di scelte precise. In secondo luogo, possiamo cercare fonti di informazione alternative, al di fuori delle piattaforme social, che ci permettano di contestualizzare e approfondire ciò che leggiamo.
Infine, possiamo imparare a usare i social media in modo più consapevole, limitando il tempo trascorso online e selezionando con cura i contenuti che condividiamo. Come suggerisce Mafe De Baggis, non dobbiamo sentirci in obbligo di migliorare i social media, ma possiamo scegliere come interagire con essi, preservando la nostra capacità di pensare in modo critico e autonomo.
In definitiva, comprendere l’architettura dell’informazione è il primo passo per trasformare i social media da fonte di caos a strumento di connessione e crescita. Solo così possiamo sfuggire alla logica della Shock Doctrine e riappropriarci del nostro spazio digitale.
Altri esempi e testi sulla Shock Doctrine
La Shock Doctrine può essere osservata in molti altri contesti storici e attuali. Ecco alcuni casi significativi.
- Russia negli anni ’90: dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il governo di Boris Eltsin adottò una terapia d’urto economica su consiglio di economisti occidentali. Le riforme portarono a una privatizzazione di massa, creando una ristretta élite di oligarchi mentre gran parte della popolazione precipitava nella povertà.
- Grecia durante la crisi del debito (2010-2015): con l’intervento della Troika (Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Commissione Europea), la Grecia fu costretta ad adottare misure di austerità severe, tra cui il taglio dei servizi pubblici e delle pensioni, la vendita di infrastrutture statali e il drastico ridimensionamento del settore pubblico.
- La crisi finanziaria del 2008 negli Stati Uniti: mentre milioni di persone perdevano le loro case e il lavoro, il governo salvò con miliardi di dollari le grandi banche che avevano causato la crisi. Allo stesso tempo, molte città e stati ridussero i finanziamenti per istruzione, sanità e altri servizi pubblici, con effetti sociali devastanti.
- Il colpo di stato in Bolivia (2019): dopo la cacciata di Evo Morales, il governo transitorio di Jeanine Áñez promosse politiche economiche favorevoli agli investitori stranieri e tentò di privatizzare risorse chiave come il litio.
Risorse per approfondire:
- Naomi Klein – No Logo (1999): un’analisi delle strategie delle grandi multinazionali per dominare il mercato e influenzare la cultura globale, connesse alle dinamiche della Shock Doctrine.
- David Harvey – Breve storia del neoliberismo (2005): un’ottima panoramica sullo sviluppo del neoliberismo e sulle strategie economiche che lo accompagnano.
- Joseph Stiglitz – La globalizzazione e i suoi oppositori (2002): un libro scritto da un premio Nobel per l’economia, che critica l’uso delle politiche neoliberiste imposte dal FMI e dalla Banca Mondiale nei paesi in via di sviluppo.
- Mark Fisher – Realismo capitalista (2009): un testo che analizza come il neoliberismo sia diventato una sorta di “realtà unica”, rendendo difficile immaginare alternative.
- William Blum – Killings Hope (1995): un’analisi dettagliata delle operazioni statunitensi nel mondo per imporre politiche economiche favorevoli alle proprie aziende e ai propri interessi.